Pubblico un articolo molto interessante apparso su “Mente politica” del 27 ottobre 2021 a firma di Paolo Pombeni:
Sembra che stia tornando di moda il riformismo, eterno fantasma che vaga nei territori della lotta politica. Forse si è capito che ridurre il bipolarismo fra destra e sinistra al desueto scontro fra generici fascisti ed altrettanto generici antifascisti era diventato una stucchevole commedia. Non che i rigurgiti di fascismo siano scomparsi: chi vuole mostrarsi un superuomo si attacca dove può ed ha bisogno di ideologie d’odio verso quello che percepisce come un mondo ostile. È però una patologia che fa parte delle debolezze umane e una quota marginale continuerà ad esserci: se non ci si riparerà sotto quell’ombrello pseudo-ideologico, se ne troveranno altri.
Non stiamo parlando però del grande contrasto che divide in due il campo del confronto politico. Oggi esso è tornato ad essere incentrato sul confronto tra massimalismo e riformismo. Che poi sia anche un retaggio di quel che successe cent’anni fa con l’affermarsi del fascismo fa parte della reazione ad una nuova incertezza sul nostro futuro: allora fu quella di ciò che sarebbe accaduto dopo una “Grande Guerra” che aveva sconvolto il mondo, oggi l’innesco è una pandemia da cui non sappiamo bene come e quando usciremo e che ha messo a nudo le molte debolezze del nostro contesto storico.
Il nuovo bipolarismo che divide il campo fra riformisti e massimalisti sconvolge i fronti politici tradizionali, perché tanto gli uni che gli altri attraversano sia le componenti che tradizionalmente si considerano “a destra” sia quelle che si proclamano “di sinistra”.
Perché il tema fondamentale è se alla trasformazione economica, sociale, culturale in cui siamo immersi si possa dare una risposta che cambia radicalmente il quadro (“rivoluzionaria” non è più un termine di moda) o se dobbiamo ragionare per rivedere le nostre coordinate ed adeguarle ad un contesto che è in fase di profonda mutazione.
Il massimalismo è continuamente fra noi. Lo vediamo nelle espressioni di molto ecologismo, nella cosiddetta “cancel culture” (quella che abbatte i monumenti dei personaggi storici perché nella loro epoca non la pensavano come noi), nelle varie demagogie che pensano di bloccare le ondate migratorie coi blocchi e coi muri, nelle pretese di considerare privilegiate e superiori tutte le opzioni personali quali che siano. Poi ci si fa meraviglia se è difficilissimo riportare alla ragione i vari no vax, no pass, e roba simile, che sono semplicemente una versione rozza e abborracciata di questo insieme di pulsioni massimaliste (né stupisce che gli eredi improvvisati di altri massimalismi storici cerchino di farsi un nido lì dentro).
Detto questo, non è che il riformismo riesca facilmente a conquistare la gran massa di quelli che in fondo il massimalismo non lo vorrebbero. Tanto per giocare un poco coi paralleli storici, vogliamo ricordare che nella famosa scissione socialista di Livorno del 1921 quelli che i comunisti e i massimalisti socialisti tacciavano di riformismo rifiutavano quella categorizzazione. Anche loro volevano essere considerati rivoluzionari, solo che ritenevano che ci si dovesse muovere con gradualità. Non volevano si pensasse che la ricerca di riforme finisse per narcotizzare la grande trasformazione a cui si aspirava.
Oggi il problema si ripresenta. Di nuovo il gradualismo viene presentato come una resa al mitico “sistema vigente”, di nuovo si predica la possibilità di cambiare verso alla storia, anche senza bisogno di sconvolgimenti violenti. Questo rende più che arduo proporre riforme che siano ragionevoli e che possano migliorare la situazione senza necessità di vendere la favola che così in poco tempo si cambierà il mondo. Quando si agisce in questo modo si è tacciati ben che vada di essere “pragmatisti”, cioè gente che aggiusta un po’ le cose, ma sarebbe accettabile solo se, come si diceva una volta con uno slogan oggi dimenticato, “le si preserva per la rivoluzione”. Guai a sostenere che una buona riforma dell’esistente lo modifica senza bisogno di stravolgere un quadro di progressi a cui siamo arrivati in un cammino storico non certo facile.
Il riformismo sembra avere uno scarso fascino. Suppone, è vero, la maturità di accettare che sia necessario convivere con dei limiti, adattarsi a comporre esigenze diverse, tenere conto che gli errori che si sono fatti in passato si devono pagare e saranno superati solo col tempo. Non è facile muoversi in quest’ottica, che implica fatica, mentre l’oppio del massimalismo illude che si possa cancellare col pensiero la realtà, allontanare da sé, almeno con la fantasia, il peso che ogni situazione storica inevitabilmente contiene.
Vi sembra un discorso astratto? Rileggetevi quel che si dice dentro quasi tutti i partiti che si disputano la scena pubblica, e vedrete facilmente come il tono dominante della comunicazione pubblica, ben sostenuto dai media, è il massimalismo. Ognuno presenta la sua soluzione miracolosa sulle tasse, sull’immigrazione, sui diritti delle scelte sessuali, e avanti con l’elenco. Il bipolarismo sembra ridursi ad uno scontro fra chi proclama il “ciascuno per sé e Dio per tutti (forse)” e chi favoleggia redistribuzioni di tutto per avere un mondo di “eguali” (basta pasticciare un poco col guru Piketty).
Una battaglia elettorale in questo contesto provocherà sconquassi, è una facile previsione. Oltre a ragionare su una buona riforma elettorale (lo si sta facendo piuttosto timidamente e malamente) converrebbe correre ai ripari per svelenire il dibattito pubblico dal fascino perverso del massimalismo. Se non ci si riesce, sarà difficile fare vere e incisive riforme e se si perde questa occasione lo si dovrà poi fare a partire dalla ricostruzione di macerie.
Paolo Pombeni
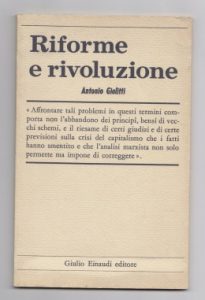
Quando ero segretario della Federazione milanese del PCI, ho avuto la fortuna di conoscere Antonio Giolitti, una persona, gentile, timida, di grande fascino intellettuale, che fu candidato a Milano nel 1987 come “sinistra indipendente” nelle liste del PCI e venne eletto senatore nel collegio di Pavia. Ho riletto il libro di Antonio Giolitti “Riforme e rivoluzione” (quarta edizione stampata a Torino per conto della Giulio Einaudi editore, il 24 luglio 1957). È una lettura da fare per chi parla di riformismo.
Fra le altre cose, mi piace ricordare che fu Commissario europeo per la politica regionale dal 1977 al 1985 e costruì la adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità economica europea.
Qui riporto il suo intervento al VIII congresso del PCI del 1956: c’era stato il XX congresso del Partito comunista dell’Unione Sovietica sulla destalinizzazione, e dal 23 ottobre al 11 novembre c’era stata la rivolta ungherese repressa dall’ intervento militare sovietico.
È lunedì 10 dicembre 1956 e al PalaEur c’è un silenzio profondo e impressionante (dicono le cronache) quando interviene il delegato di Cuneo, Antonio Giolitti.
In quel congresso, Amendola e Napolitano si contrapposero a Giolitti.
Nel 2006, Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, andò a trovare nella sua abitazione romana Antonio Giolitti e riconobbe che cinquant’anni prima aveva avuto ragione lui. Per inciso, era anche un riconoscimento a Giuseppe Di Vittorio che non condivise la posizione del PCI.
Giolitti morì a 94 anni nel 2010. Ecco il testo dell’intervento pubblicato sull’Unità .
Per comprendere i gravi avvenimenti e i complessi problemi che si manifestano nel mondo capitalista e nel mondo socialista, dobbiamo risalire – come ci insegna Marx – ai fattori di ordine strutturale. Le nuove tecniche della produzione e della organizzazione del lavoro, del controllo e della pianificazione economica, hanno aperto problemi nuovi nel seno stesso delle contraddizioni del capitalismo, modificandone le forme e i modi di sviluppo; contraddizioni imprevedute si sono rivelate nel modo di produzione della società socialista. Nel nostro paese le contraddizioni del capitalismo si presentano, per questi nuovi aspetti, acuite ed esasperate perché, agli sviluppi della tecnica in alcuni settori e in alcune zone, si accompagna il permanere e anzi l’aggravarsi di croniche arretratezze. Si accentuano così gli squilibri, caratteristici nel nostro paese, tra Nord e Sud e tra città e campagna. Ma la tendenza che ne deriva è comune, e comuni le conseguenze politiche: il contrasto tra forze produttive e rapporti di produzione pone sempre più imperiosamente l’esigenza delle riforme di struttura.
L’avvertiamo anche noi nella provincia di Cuneo, che non è certo all’avanguardia del progresso tecnico. Le grandi lotte contadine che hanno agitato e continueranno ad agitare le nostre campagne puntano sì su alcuni obiettivi limitati di carattere rivendicativo, ma esse implicano – e spesso indicano anche esplicitamente – problemi di trasformazione sociale e quindi anche il problema del potere. I contadini del Cuneese hanno capito che solo un governo democratico delle classi lavoratrici potrà veramente risolvere i loro problemi. Di qui la piattaforma unitaria e la partecipazione di massa a quelle lotte; di qui il contributo concreto che esse recano alla politica della via italiana al socialismo.
Noi, che vogliamo elaborare e percorrere la via italiana al socialismo, dobbiamo partire appunto dai problemi di fondo, dalle strutture, dal processo produttivo e dalle forze sociali che in questi problemi sono più direttamente impegnate.
Come scriveva Gramsci sull’Ordine Nuovo, «Se non si gettano le basi del processo rivoluzionario nell’intimità della vita produttiva, la rivoluzione rimarrà uno sterile appello alla volontà, un mito nebuloso, una morgana fallace: e il caos, il disordine, la disoccupazione, la fame inghiottiranno e stritoleranno le migliori energie proletarie». L’azione al livello delle strutture, nell’intimo del processo produttivo, è indispensabile e direi quasi pregiudiziale per la costruzione del socialismo col metodo democratico e nelle forme adeguate alle nostre caratteristiche nazionali. Laddove si è avuta la conquista violenta del potere da parte della classe operaia, il problema si è posto in termini capovolti, giacché si trattava di colmare un enorme vuoto esistente sotto il potere politico, cioè creare al livello delle strutture nel processo produttivo la capacità ed il potere di direzione della classe operaia, fondati sull’effettivo dominio delle forze produttive e dei rapporti di produzione, e non solo sui fattori volontaristici e coercitivi.
Nell’Unione Sovietica ciò venne sostanzialmente realizzato attraverso una nuova e più avanzata forma di democrazia articolata nei soviet e con forme di democrazia diretta nei luoghi di produzione. Così il sistema socialista conservò la sua natura democratica ed il consenso popolare,nonostante le violazioni della legalità ed i metodi tirannici dell’esercizio del potere, superò vittoriosamente il collaudo decisivo della guerra, e seppe poi trovare in se stesso la capacità di correggere e superare gli errori. Nelle democrazie popolari, il processo di costruzione democratica della società socialista venne interrotto al suo inizio, ed in alcuni casi venne sopraffatto dall’involuzione burocratica del potere statale.
Diversa è la strada che dobbiamo percorrere noi, nell’epoca della coesistenza e delle vie nazionali al socialismo. È vero che il processo di distensione non è irreversibile come i fatti ci hanno dimostrato, ma la prospettiva della coesistenza dev’essere quella nella quale e per la quale noi operiamo. Allora le vie percorse dall’Urss e dalle democrazie popolari sono per noi esperienze da valutare criticamente, non modelli da imitare (nel programma, invece, si parla ancora dell’Unione Sovietica come di un «modello»).
Per noi, la funzione dirigente della classe operaia deve esercitarsi innanzitutto nel processo produttivo, e di qui conquistare il potere politico. Quindi, elemento essenziale è quello che Gramsci chiamava la coscienza che l’operaio ha di se stesso come produttore. Ciò significa che non si può costruire il socialismo senza la partecipazione attiva e consapevole della classe operaia e delle altre classi lavoratrici che operano nel processo produttivo. Vale a dire, non si può costruire il socialismo senza le essenziali libertà democratiche: tutt’al più si possono creare le premesse economico-giuridiche del socialismo (nazionalizzazione dell’industria, legge agraria eccetera).
La società socialista, nel suo stesso farsi, elabora ed applica nuove e più avanzate forme di democrazia – anche diretta – specie per quanto riguarda la partecipazione dei lavoratori alla direzione dell’attività produttiva. Ma essa fa anche proprie le libertà formali dei regimi borghesi, riempiendole di quel contenuto concreto e universale che esse possono avere, solo quando non sono limitate e falsate dall’esistenza di privilegi di classe.
Perciò noi oggi possiamo e dobbiamo proclamare, senza riserve e senza doppiezze, che le libertà democratiche, anche nelle loro forme istituzionali di divisione dei poteri, di garanzie formali, di rappresentanza parlamentare, non sono «borghesi» ma sono elemento indispensabile per costruire la società socialista nel nostro paese. Questo, a mio avviso, bisogna dire, e non soltanto che noi oggi vediamo la possibilità di arrivare al socialismo attraverso la democrazia e la Costituzione. È vero, come ha detto il compagno Togliatti, che ciò non comporta affatto una revisione dei nostri principî; credo tuttavia che ciò imponga un riesame, alla luce dei principî marxisti e dell’esperienza storica, della teoria leninista della conquista del potere.
Ma anche la più solenne nostra dichiarazione sul valore permanente delle libertà democratiche è parola vana se continuiamo a scrivere nel nostro programma e nelle nostre tesi che gli errori e i delitti denunciati al XX congresso non hanno intaccato la permanente sostanza democratica del potere socialista (dico potere, non sistema), e se definiamo legittimo, democratico e socialista un governo come quello contro il quale è insorto il popolo di Budapest il 23 ottobre.
Ecco dei casi di doppiezza che bisogna condannare ed eliminare. Non che la violenza resti così esclusa dalla storia: ma proprio perché non si può escludere che la violenza della reazione obblighi la classe operaia a rispondere con la violenza, noi dobbiamo garantire (garantire a noi stessi e al popolo, non a coloro che con arrogante malafede ci chiedono delle garanzie) che anche in quel caso il regime socialista si fonderà e svilupperà su basi democratiche. La maggior garanzia consiste nel fatto di portare la democrazia dentro di noi. Perciò io credo necessaria non una revisione ma una giusta interpretazione e applicazione del centralismo democratico, il quale, come ha scritto Gramsci, «offre una formula elastica, che si presta a molte incarnazioni; essa vive in quanto è interpretata e adattata continuamente alle necessità».
Io penso che il centralismo democratico deve essere concepito e applicato in modo che, mentre viene assicurata la rigorosa osservanza delle direttive deliberate dalla maggioranza, sul piano dell’esecuzione, si mantiene aperto il dibattito delle opinioni e delle idee, che è condizione indispensabile di una vera democrazia. Solo così si assicura una unità reale del partito. Il giudizio, la convinzione, non possono venire imposti per disciplina: occorre la persuasione, attraverso il dibattito, il confronto aperto e leale delle opinioni diverse.
L’unità del partito non si difende aiutandolo ad andare su una strada che si giudica sbagliata. Se si è convinti che viene commesso un errore si ha il dovere di dirlo e di battersi per correggerlo, proprio per difendere il partito e gli interessi della classe operaia. In Ungheria e in Polonia hanno difeso il partito non i compagni che per una mal intesa disciplina hanno taciuto, ma quelli che hanno criticato. Se Gomulka non avesse mantenuta ferma la sua posizione di dissenso, forse in Polonia le cose sarebbero andate come in Ungheria.
Molte volte il gioco dell’avversario lo fa chi tace. Ma tutti ibuoni propositi di realizzare una vera democrazia nel partito vengono smentiti e vanificati quando un compagno che critica viene accusato di tradimento, diventa un agente del nemico, come è stato fatto anche negli ultimi tempi. Ecco un altro esempio di doppiezza.
Gli stessi fattori di ordine strutturale che, come dicevo all’inizio, determinano questa profonda esigenza democratica, sono anche all’origine della spinta unitaria della classe operaia. I problemi nuovi aperti dal progresso tecnico nelle grandi fabbriche e parallelamente l’aggravarsi dei fenomeni di arretratezza (come abbiamo potuto sperimentare con le iniziative cosiddette di rinascita in provincia di Cuneo) spingono i lavoratori a cercare nell’unità, sindacale e politica, la forza per imporre le loro soluzioni.
È di qui, in misura ben più determinante che non dall’episodio di Pralognan, che nasce il processo di unificazione socialista, che interessa tutte le forze di ispirazione socialista e quindi anche il nostro partito. Perciò non mi sembra giusto considerarci estranei a questo processo, e neppure giudicare senz’altro non attuale il problema del partito unico. Io credo anzi che la via italiana al socialismo avvicini questa prospettiva.
L’esigenza della via italiana al socialismo e di un partito della classe operaia capace di percorrerla fino in fondo senza esitazioni e senza remore non nasce dunque improvvisamente col XX congresso, come necessità di adeguarsi a una situazione nuova, ma deriva da motivi ben più profondi e permanenti. Ragione di più per raccogliere tutti gli insegnamenti e trarre tutte le conseguenze del XX congresso. È vero che non abbiamo aspettato questo per delineare e intraprendere la via italiana. Ma senza dubbio i rapporti tra i partiti comunisti prima del XX congresso e la concezione dello Stato guida hanno posto limiti sensibili a quella politica. La novità oggi consiste soprattutto in questo: che non esiste più il rischio di una rottura come prezzo da pagare per una piena autonomia di giudizio e di azione. A ciò potrà certo giovare l’istaurazione di rapporti bilaterali. Quel prezzo fu imposto a Tito sul piano internazionale e all’interno dei singoli partiti a coloro che dissentivano o anche soltanto dubitavano.
Anche nel nostro partito: non c’è stato forse detto, all’epoca della condanna di Tito e poi ancora a proposito del processo Rajk, che quello era il modo di difendere la dottrina marxista-leninista e l’unità della classe operaia e che qualsiasi esitazione in questo campo doveva essere combattuta e sradicata senza pietà? Qui si tocca la questione della corresponsabilità.
Non abbiamo soltanto accettato senza critica certe teorie sbagliate e la esagerata esaltazione di un uomo, abbiamo anche partecipato all’applicazione di metodi errati; alcuni, e io tra questi, perché hanno taciuto quando dubitavano e dissentivano, altri perché hanno difeso e sostenuto quei metodi. Perciò deve essere chiaro che noi facciamo la più radicale autocritica di tali errori, denunciandoli e condannandoli anche come errori nostri, per la parte che ci spetta.
Questo è necessario, se la correzione ha da essere completa, senza residui. Tanto più che alcuni di questi metodi errati devono avere radici ben profonde, se anche dopo il XX congresso sono tornati in vigore in relazione ai fatti di Ungheria: di nuovo abbiamo visto combattere e sradicare senza pietà le opinioni di quei compagni – e io sono fra costoro – che hanno manifestato dubbi e dissensi in merito alla definizione di controrivoluzione data della rivolta popolare del 23 ottobre e di «potere legittimo, democratico e socialista» data del governo ungherese di allora, quei compagni che hanno giudicato che l’intervento sovietico poteva giustificarsi in funzione della politica dei blocchi militari, ma non in base ai principî del socialismo.
Quelle opinioni contrarie dovevano poi essere riconosciute valide o almeno legittime: ma intanto erano state soffocate ed era stata sconfessata la loro espressione più autorevole, la dichiarazione della Cgil.
Effettiva libertà di opinione e di discussione in seno al partito, nell’ambito del centralismo democratico; accettazione incondizionata delle libertà democratiche come elemento permanente della via italiana al socialismo; piena autonomia di giudizio e di azione nei rapporti con gli altri partiti su scala internazionale: queste a mio avviso le condizioni indispensabili per un effettivo rinnovamento. Si tratta di cambiare e correggere, non solo di continuare e migliorare; e cambiare anche gli uomini, che non si possono correggere. Solo così il Pci potrà essere – come scriveva Gramsci sull’Ordine Nuovo – il partito delle masse che vogliono liberarsi coi propri mezzi, autonomamente, dalla schiavitù politica e industriale attraverso l’organizzazione dell’economia sociale e non il partito che si serva delle masse per tentare imitazioni eroiche dei giacobini francesi. Solo così potremo partecipare come attori, anzi come protagonisti, al faticoso processo in cui oggi si trova impegnato il movimento operaio che cerca la sua unità sindacale e politica
(Applausi).

