Pubblico qui la prefazione che il nostro amico “migliorista” Pierfranco Bianchetti mi ha chiesto per il suo libro che consiglio di comprare e di regalare: “Cinemiracolo a Milano – cineclub, cinema ‘essai e circoli del cinema dalla Liberazione ad oggi”.
A presentare questo libro, ci siamo ritrovati, un mese fa, al teatro Franco Parenti, con Lorenzo Vitalone, (che faceva gli onori di casa), con Romano Fattorossi, (presidente della Associazione italiano amici dei cinema d’essai e organizzatore di molti festival), con Maurizio Nichetti.
E giustamente Nichetti ha messo in rilievo quanto è cambiato il cinema e la nostra vita di “consumatori” di cinema: oggi vediamo i films sui telefonini, e passiamo le sere a cercare il film da vedere su sky, su netflix, su primevideo, ecc., e nella ricerca del film, spesso si fa notte.
Ovviamente, nessuno è nostalgico del passato, e questo libro non è la manifestazione della nostalgia del “bel tempo che fu”, Ma la storia di Milano, contenuta in questo libro, ci insegna che, quando chiude un teatro, un cinema, o si riduce uno stadio (luogo di sport e di grandi concerti, con presenze di decine di migliaia di persone), o quando si costringono a chiudere centri e circoli culturali (per un aumento spropositato degli affitti), si colpisce la cultura, il pluralismo, la vita democratica, la dimensione sociale della nostra esistenza e della nostra comunità.
Quella sera al Parenti, c’è stata anche la proiezione del trailer del film “La musica nel cinema di Pasolini” con la regia di Claudio Chianura, a cui va la mia gratitudine, doppia. Per avermi fatto ricordare il mio amico Luis Bacalov che curò la colonna sonora de “Il Vangelo secondo Matteo” , per cui ebbe anche la nomination all’Oscar, prima di vincere la statuetta con “Il postino”. Per avere pubblicato questo libro di Bianchetti con la Haze-Auditoriumedizioni, che nel suo bellissimo catalogo ha aggiunto anche un volume con gli “Scritti sulla musica” di Andrea Mascagni, a cui è dedicato un dvd, realizzato con CAB e Rai Alto Adige. Due libri, quelli di Bianchetti e di Mascagni, che vale la pena di leggere.
—————–
Questo libro è un atto d’amore verso il cinema e verso Milano.
Il Novecento ci ha regalato una nuova forma d’arte, il cinema, che ha cambiato la percezione dell’arte e della musica.
E Milano non poteva che essere per ragioni economiche, sociali e culturali in prima fila nell’apprezzare questa forma di intrattenimento e di arte, che ha cambiato tante cose nella vita degli uomini e delle donne. Il cinema è stato anche, senza che lo spettatore ne fosse consapevole, e spesso senza che gli stessi autori lo volessero, uno strumento di lotta contro l’ignoranza e contro il sopruso, contro le ingiustizie.
Ed era normale “andare al cinema”, solo dopo si andava a “vedere il film” o “quel film.” Un tempo si andava nei cinema di terza o di seconda visione, mentre quelli di prima visione erano concentrati in centro, in particolar modo in corso Vittorio Emanuele: ancora negli anni Ottanta c’erano ventinove sale.
E in quell’andare al cinema c’era qualcosa di più della ricerca dell’intrattenimento: c’era un fatto straordinario. le persone si ritrovavano in un posto a condividere sentimenti, c’era uno stare insieme, una socializzazione, che abbatteva spesso barriere sociali e culturali. Anche con i problemi economici seri del dopoguerra o delle tante ricorrenti crisi economiche, come scrive Maurizio Porro, “Però c’era gioia, una partecipazione collettiva nell’andare al cinema che si è totalmente persa. La gente, nonostante entrasse a metà film era più rispettosa, stava in silenzio. C’era una certa religione, un timore reverenziale per la sala buia, per queste immagini gigantesche che si stavano sempre più affinando. Tutto questo dava una certa sacralità che il cinema di oggi purtroppo ha perso perché la diffusione televisiva l’ha smitizzato. Inoltre andare a vedere un film non era solo un’attività serale come adesso: capitava di andare il pomeriggio e di trovare tanta gente. Ora invece siamo sempre in tre gatti, a meno che non sia un film molto atteso e promosso, la gente si raduna al penultimo spettacolo e all’ultimo spettacolo. Prima invece le sale aprivano anche la mattina. L’Astra, che allora era collegato alla Metroastra perché era collegato alla Goldwin Meyer, apriva alle 10.30 e la leggenda metropolitana era che si andasse bigiando la scuola. Ma non c’erano solo studenti, c’era persino un pubblico che andava al mattino”.
Milano con la Lombardia è sempre stata la realtà in cui vi era il pubblico più numeroso d’Italia: fra il 1950 e il 2019 nella nostra regione c’è stato in media il 16% di tutto il pubblico nazionale e il 19% degli incassi totali.
Certo, il pubblico si è ridotto: nel 2019 a livello nazionale è un sesto di quello del 1950, e a Milano un quinto. In termini di incassi, siamo al 58% del 1950 (l’aumento dei prezzi dei biglietti ha in parte attenuato la diminuzione degli spettatori) e a Milano siamo al 59%.
Ma a Milano, più che nel resto d’Italia, c’è stato un fiorire di centri di cultura cinematografica, di cineclub, di cineforum, di creazione di operazioni che portavano l’attenzione per il cinema ad un livello di partecipazione consapevole di massa. Con queste attività di formava una coscienza critica, una partecipazione culturale di massa, di persone che apprezzavano i films, ma lo amavano a tal punto di sfiancarsi nei famosi dibattiti “dopo la proiezione”. Io stesso non so a quanti dibattiti ho partecipato, dopo la proiezione della “Battaglia di Algeri” nei “festival dell’Unità” nei quartieri di Milano o nei Comuni della provincia.
Ma come dice Lionello Cerri, “a ripensarci dico che siamo fortunati ad aver vissuto quell’epoca, in una generazione, voglio dire, che ha creduto nell’impegno, nella socializzazione, nella cultura”.
“Nella convinzione che il cinema fosse l’arte più appropriata per formare spirito critico e coscienza civile e democratica della società del nostro secolo” – come scrive Vittorio Giacci – crescevano ovunque cineforum, centri di incontro, di aggregazione e intanto nascevano istituzioni prestigiose come la Cineteca Italiana, di Gianni Comencini e Walter Alberti.
Nel libro, si parla di tanti personaggi (Ugo Casiraghi, Massimo Maisetti, Alberto Lattuada, Luigi Comencini, Luciano Emmer, Paolo Grassi, Dino Risi, Brunello Vigezzi, Gianni Locatelli, William Azzella, Giovanni Buttafava, Guido Martinotti, per citarne solo alcuni), e di tante iniziative che hanno fatto di Milano un laboratorio di idee, di impegno civile, culturale, di partecipazione democratica, di partecipazione politica, di quel concorso alla formazione della politica nazionale, che non può esserci se non attraverso quel vasto tessuto di sezioni di partito, di circoli culturali.
Negli anni ottanta c’erano a Milano, diffuse nel territorio cittadino, più di quattrocento organizzazioni politiche e culturali, compresi i cineforum, che erano la linfa vitale di un pluralismo politico, culturale, ideologico, che arricchiva Milano: cattolici, comunisti, socialisti, liberali, repubblicani, tutti partecipavano a questo straordinario fiorire di iniziative. E non dimentichiamoci che i film venivano proiettati non solo nei cinema commerciali, ma nei tantissimi cinema oratoriali, nelle attività dell’Enal (ente nazionale assistenza lavoratori), nel circuito dei cinema d’essai, dei cineclub, dei circoli del cinema, dei cineforum. Ho un amico liberale, conosciuto in Consiglio comunale, che ancora oggi organizza un centro di cultura cinematografica.
Come dice Paolo Mereghetti a proposito dell’Obraz, “È lì che abbiamo imparato ad amare davvero il cinema: non l’avessimo fatto, non avremmo potuto appassionarci neppure alle riviste che ce ne parlavano”.
E in questo libro, giustamente si parla del ruolo del Comune, non solo nella funzione di promozione della cultura cinematografica, ma anche come stimolatore della produzione filmica. Cosa che è iniziata con Antonio Greppi ed è proseguita con tutti i Sindaci fino a Carlo Tognoli e a Paolo Pillitteri. Ed una cosa di cui sono orgoglioso è quella di aver costituito nel 1988 l’”Ufficio Cinema” affidato all’autore di questo libro. E Bianchetti, allora come oggi, dimostra un amore smisurato per il cinema, per Milano, e una affettuosa ammirazione per tutti coloro che hanno messo la loro passione al servizio della cultura cinematografica.
E lo dico senza mezzi termini, rimpiango quel fermento culturale, quella passione politica, civile e culturale che ci faceva incontrare, discutere, litigare anche, ma ci dava il senso di una comunità, ci costringeva a socializzare la nostra esistenza, togliendoci dalla pigrizia dell’isolamento domestico.
È il rimpianto di cui parla Vittorio Giacci “Alla luce della “desertificazione” culturale in cui ci si trova oggi a vivere, scomparsi di fatto i cinema d’essai e spariti i cineclub; del tutto assente il ruolo della critica sostituita ormai da una esclusiva e autoritaria promozione al consumo; estremamente ridotta l’offerta di cinema in sala e saltata anche la più tenue presentazione critica dei film da parte della televisione, non si può che guardare con rimpianto a quell’epoca fertile e felice e giudicare con spirito anche autocritico certi nostri eccessi”.
E quanto sarebbe bello, giusto e utile per la nostra vita culturale e democratica che il Comune recuperasse il Cinema De Amicis per riprendere un cammino interrotto: sarebbe anche una operazione di bonifica edilizia, oltre che di riparazione culturale, tra l’altro persone disposte a dare la loro opera per questa operazione ci sono. E siccome sognare fa bene al cuore e all’anima, questo libro può essere di ulteriore stimolo perché le scuole in disuso possano diventare librerie e centri di cultura cinematografica: dando così un senso anche alle giornate di tante persone “adulte” che potrebbero mettere a disposizione tempo e impegno a favore degli altri. Così come dando maggiori risorse economiche e personale, si possono far diventare le biblioteche rionali dei centri culturali per una maggiore diffusione della cultura cinematografica, teatrale, musicale e letteraria.
Grazie dunque a Pierfranco Bianchetti perché con questa ricostruzione storica ci ha dato la dimensione veritiera del ruolo di Milano, del suo storico primato culturale e del suo amore per l’arte e per il Novecento, di cui il cinema è la simbolica espressione.
Luigi Corbani

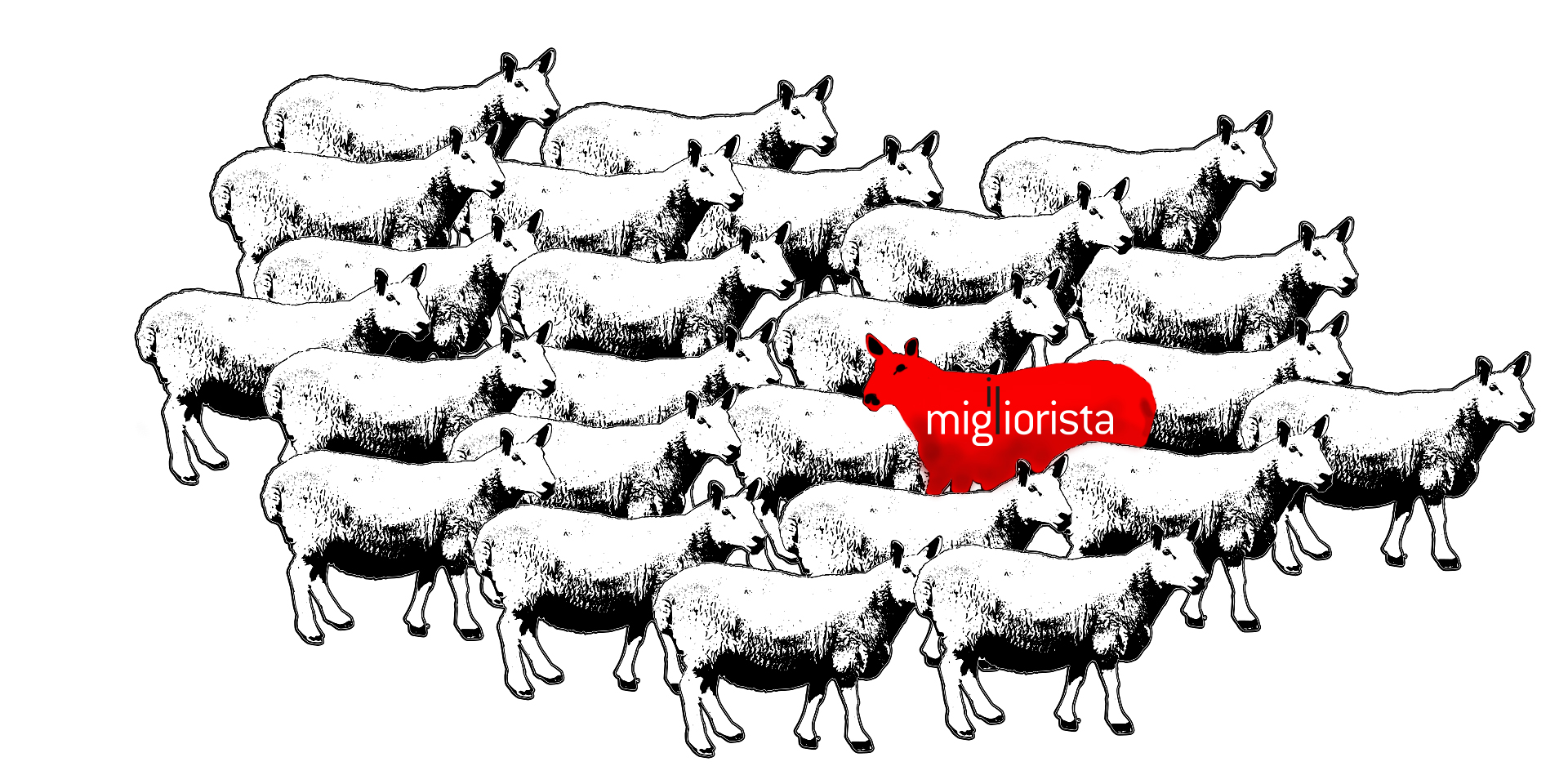
Che bello leggere di cinema a Milano! Voglio prendere con gioia il libro segnalato quanto prima perché la mia “golosità “ di cinema è grande e soprattutto se riguarda Milano.
Grazie!
Grazie spero che il mio libro le faccia piacere grazie
Buona sera, sono Carlo Re ,e scrivo per conto di una sala in periferia a Bareggio, il Cineteatro S. Luigi. Volevo comunicare che dopo notevoli sforzi tecnici ed economici, siamo riusciti a rendere operativo il nostro doppio impianto di proiezione in 70 MM. e siamo lieti di rendere noto che il 12 Gennaio prossimo nell’ambito della nostra rassegna, riproporremo Oppenehimer appunto in 70 mm. Come molte realtà siamo un gruppo di volontari che lotta con le unghie e con i denti per tenere viva la nostra sala facendo apprezzare al pubblico la meraviglia del bel Cinema.
Vi saremmo molto grati se tramite i vostri canali rendeste nota la nostra iniziativa. Dopotutto, saremo una delle quattro sale in Italia in grado di proiettare il 70mm come Nolan comanda. Grazie
Ho provveduto a diffondere la notizia della vostra bella, pregevole iniziativa. Bravi!