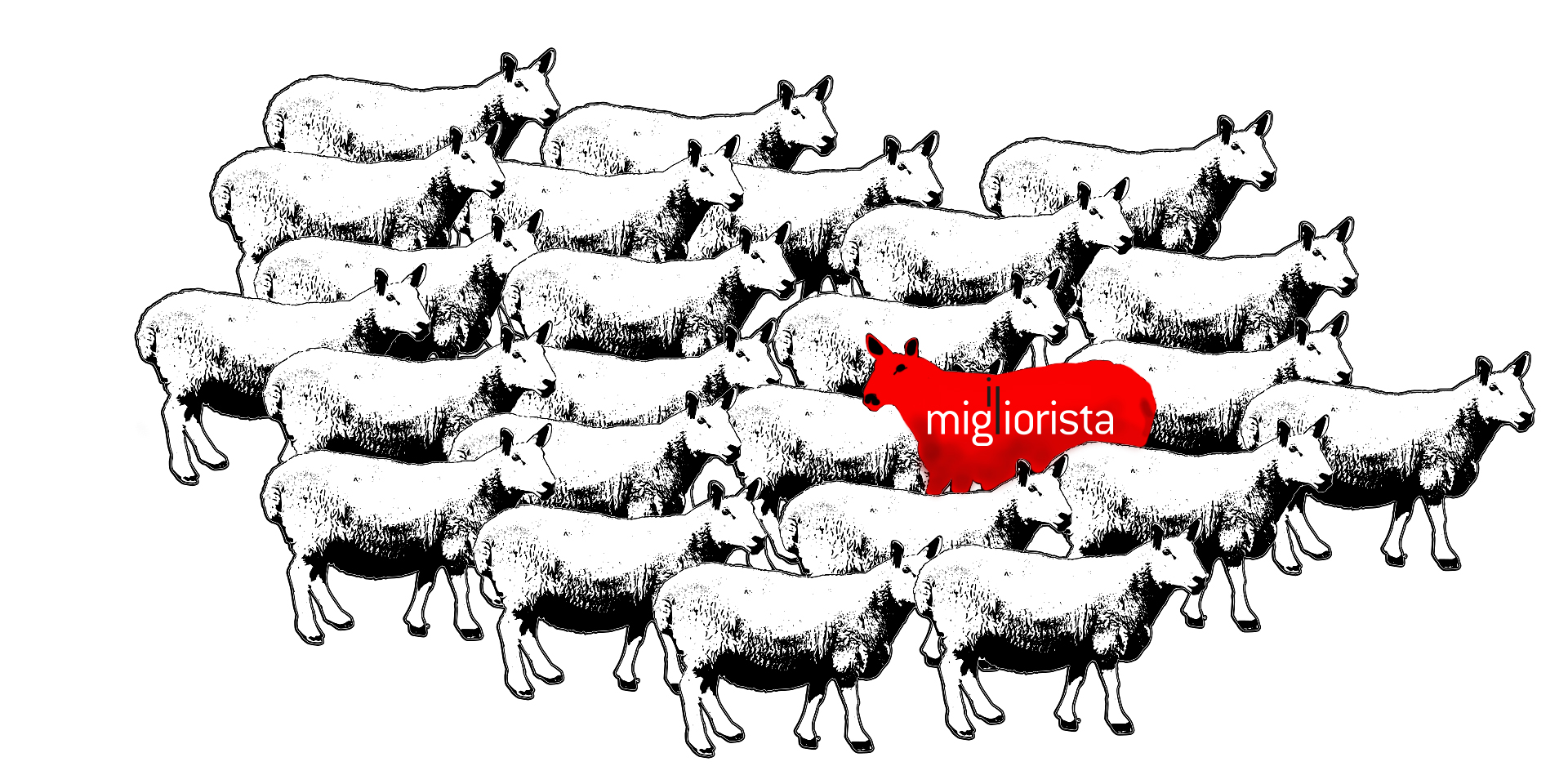Se la società italiana può permettersi di lasciare inutilizzata una gran parte delle sue risorse umane, è un po’ colpa dell’articolo 37 della Costituzione. Poche donne italiane infatti hanno un’occupazione, più di metà di loro – circa il 51 per cento – non ha un’occupazione né un reddito, e questo colloca l’Italia al penultimo posto nella classifica della partecipazione femminile al lavoro nei 27 paesi dell’Unione europea. A lasciare inerte tutto questo ben di Dio – energia, creatività, competenza, gioia di vivere e di fare – è una mentalità arcaica, che si sposa perfettamente con un costume pauperista e una politica inetta. Arcaica perché per millenni le donne hanno lavorato, è vero, ma come i muli, al servizio della famiglia e senza stipendio, più come schiave che come esseri umani. Pauperista perché – come dimostra l’inazione del governo in carica – è scoraggiata l’iniziativa, incentivato il sussidio e sconsigliate l’indipendenza e la mobilità.
La mentalità arcaica è incorporata nell’articolo 37, che comincia così: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione». La prima affermazione contraddice in parte la seconda: la lavoratrice ha gli stessi diritti del lavoratore, ma la sua «essenziale funzione» è familiare. Anfibio, l’articolo 37 esprime la cultura che considera il lavoro femminile un ausilio e tratta le donne come delicate creature bisognose di tutela. Basta guardarsi intorno per capire che sono più che altro le donne a tutelare il resto dell’umanità, ma a titolo gratuito: provvedono ai bambini, curano i malati, assistono gli anziani, lavano piatti e camicie. Soltanto se hanno fortuna, potranno compilare bilanci, amministrare patrimoni, città e regioni, progettare nuovi materiali, scrivere poesie o romanzi, insegnare a scuola e molto, molto altro, ma in tal caso con un salario che dà dignità e garantisce l’indipendenza.
La rivoluzione industriale oltre cent’anni fa e la rivoluzione tecnologica più vicina a noi hanno invece estremo bisogno di brain not brawn, di cervello e non di muscoli, rovesciando l’abitudine rurale che per far fruttare i campi è necessario il maschio, ausiliaria le femmina. In Italia è tuttora diffusa la convinzione – sostenuta da ripetute prediche papali – che il posto giusto per una donna sia la casa, che le lavoratrici non fanno figli e che, in fondo, il lavoro femminile è un lusso come i sedili in pelle nell’automobile.
Così siamo arrivati ai nostri giorni, bollati dal rapporto 2019 di Oxfam, il quale snocciola dati vergognosi per l’economia nazionale (che spreca risorse) e per la civiltà (che vuole le donne mantenute e sottomesse): l’Italia non è soltanto al ventiseiesimo posto nella classifica europea della partecipazione femminile al lavoro, ma occupa anche il posto numero 118 nella classifica di 142 paesi del mondo; una donna su quattro svolge un lavoro al di sotto delle sue capacità, solo 54 lavoratrici su cento hanno uno o più figli e una su dieci lotta per scongiurare la povertà.
Mentre sarebbe urgente mettere all’opera le risorse femminili (a maggior ragione perché l’istruzione è un investimento della società), risolvere la conciliazione tra famiglia e lavoro, scoraggiare il precariato e allentare la morsa delle tasse sia sui datori di lavoro sia sulle lavoratrici madri o sulle donne sole, è tuttora diffuso il malcostume che discrimina: nei colloqui per l’assunzione, la domanda di rito «Ha in progetto di sposarsi? Di fare figli?» è tuttora rivolta alle candidate, mai ai candidati. I maschi sono esentati dal mobbing al rientro dal congedo di maternità («Ti chiudono in uno stanzino», «Non mi convocano più alle riunioni», «L’aumento l’hanno dato all’ultima arrivata, che è single»). Salari e stipendi sono differenziati del 20 per cento circa, secondo i casi, le mansioni e le aziende. Le promozioni sono di preferenza maschili, le carriere femminili lente e nella penisola risuona l’antico lamento. «Ah, le donne non fanno più figli». Perché hanno un lavoro? No, perché non hanno un lavoro e un reddito. L’ultima vergogna sta nel fatto che, negli anni di crisi, la disoccupazione maschile si è aggravata più di quella femminile, visto che le lavoratrici costano meno, accettano salari inferiori per non restare fuori dal mondo del lavoro.
A coccolare e confermare la convinzione arcaica che il posto giusto delle donne sia la casa, ci si mettono d’impegno la pubblicità, i mezzi d’informazione, i libri di testo. «Quando Gaia ha male al pancino ….» comincia uno spot televisivo dei fermenti lattici, e mostra la mammina che fa guarire la piccola (non il papà). Un libro di testo di seconda elementare mostra la famiglia al mare: il papà rema sulla barca, un bambino nuota, l’altro gioca a palla e la mamma è sdraiata a far niente. La statistica smentisce ogni quadretto zuccheroso: se una donna vuole raggiungere il reddito di un collega, deve lavorare 59 giorni in più in un anno; nelle famiglie giovani con figli la madre lavora un’ora in più abbondante al giorno rispetto al padre. Be’, se «Ahi, le donne non fanno figli», non dovranno neppure raccontare ai bambini «C’era una volta il sindacato, c’era una volta il femminismo» prima del bacio della buonanotte.
Marta Boneschi